La Scrittura Sacra: Un’Opera di Costante Evoluzione e Revisione
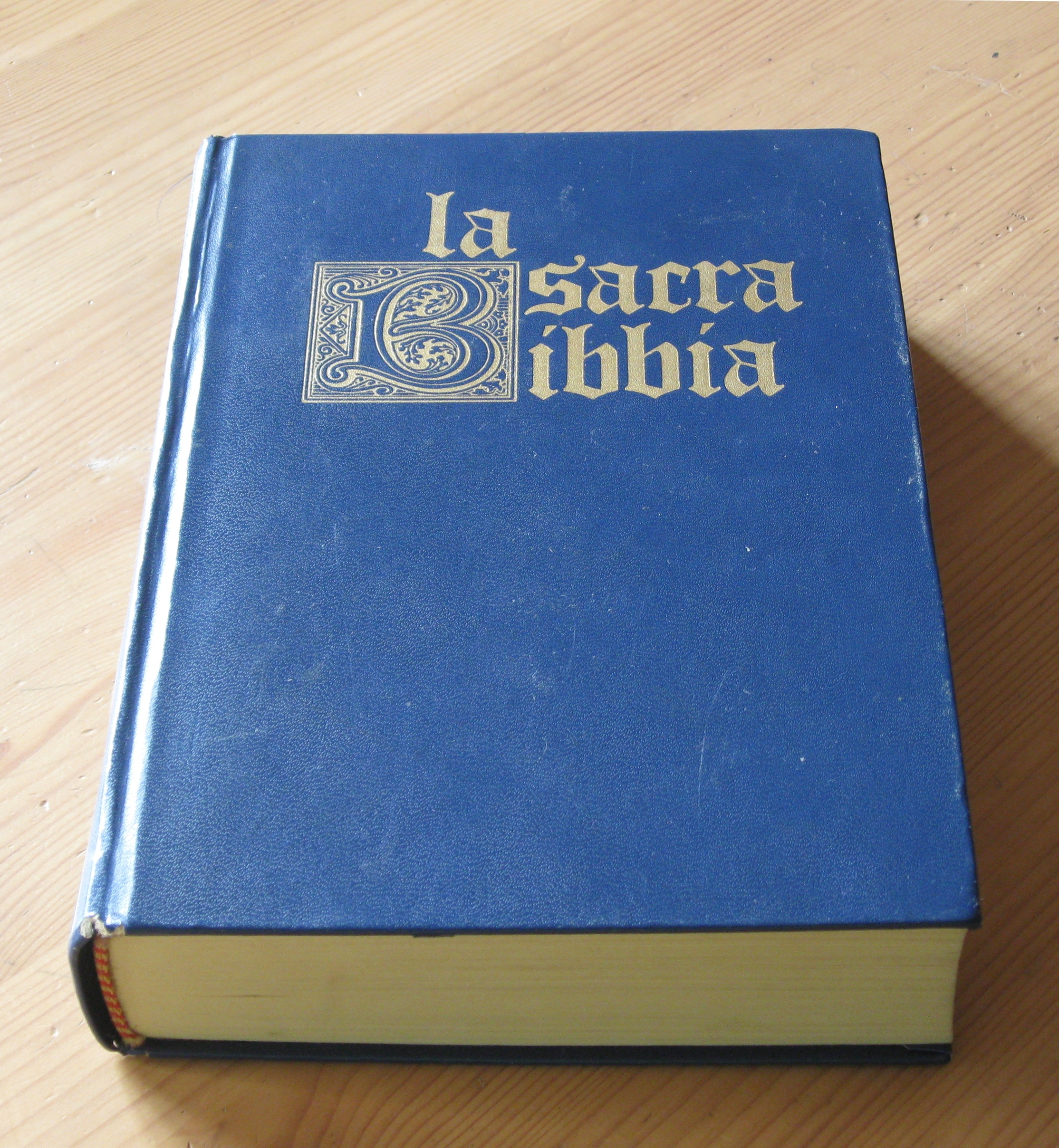
Un lettore attento ha recentemente contestato le mie affermazioni sulla profonda manipolazione subita dalla Bibbia nel corso dei secoli, sostenendo di non aver riscontrato incongruenze in una sua analisi esegetica dei Vangeli, basata sui testi greci originali e su fonti autorevoli come il Merk. È importante precisare che queste non sono ipotesi personali, ma conclusioni ampiamente diffuse nel mondo accademico, ebraico e cristiano.
L’esistenza stessa del “Bible Project”, un’iniziativa avviata nel 1958 da un gruppo di eminenti studiosi ebraici, dimostra l’enorme complessità del testo biblico. L’ambizioso obiettivo di ricostruire un testo il più possibile fedele all’originale, in un lasso di tempo previsto di ben 200 anni, sottolinea la vastità del lavoro e la consapevolezza delle numerose revisioni intervenute. Ad oggi, si stima che siano stati ricostruiti solo 11 libri, e gli aggiornamenti sui progressi sono rari, a causa della delicatezza dell’argomento.
La questione della paternità dei testi biblici è in sé problematica. La lingua ebraica, ad esempio, si sviluppò da un dialetto subfenicio secoli dopo gli eventi narrati nell’Esodo, rendendo assai dubbia l’attribuzione del Pentateuco a Mosè. L’incertezza sulla reale autorevolezza dei testi è evidente anche in altri casi: si stima che solo 125 dei 1275 versi di Ezechiele siano attribuibili con sicurezza al profeta, mentre il libro di Isaia sarebbe frutto del lavoro di almeno tre autori distinti, nel corso di 250 anni, come sottolinea il professor Angelo Penna. I Vangeli, poi, esistono in circa 2500 manoscritti, ognuno con differenze, a volte significative.
L’esistenza di numerosi codici biblici, ognuno con una propria storia (Codex Cairensis, Ms Or 4445, Codex Aleppensis, Codex Leningradensis, Codex Vaticanus, e il codice ge’ez ritrovato in Etiopia nel 2021), evidenzia la moltitudine di varianti testuali. A queste si aggiungono i testi di Qumran, la Settanta, la Vulgata, i Targumim, la Peshitta e il Pentateuco Samaritano, con significative discrepanze. Ad esempio, mentre Mosè è generalmente presentato come ebreo, nei Targumim è descritto come un egiziano appartenente alla casta sacerdotale degli Yahudae. Inoltre, secondo questa versione, non furono gli ebrei a fuggire dall’Egitto, ma egiziani appartenenti a diverse classi sociali, una tesi avvalorata dalla notevole ricchezza che trasportavano. Come asserisce il professor Lee I. Levine, l’identità ebraica si formò in un lungo processo storico.
Le analogie tra l’inno ad Aton, il salmo 104 e i dieci comandamenti con le 42 dichiarazioni dell’anima al cospetto di Osiride suggeriscono influenze esterne. Anche la Bibbia comune presenta incongruenze, come la definizione di Mosè come “egiziano” (Esodo 2, 16-19).
Secondo molti studiosi, la versione definitiva della Bibbia sarebbe stata redatta alla fine dell’esilio babilonese (538 a.C.), spiegando possibili influenze sumero-accadiche nella Genesi. Yahweh, il Dio cristiano, non avrebbe avuto inizialmente una presenza fisica, subentrando gradualmente agli Elohim, conservando però tracce della loro precedente importanza.
In sintesi, la Bibbia è la narrazione della storia di Israele e del patto con Yahweh, una divinità bellica tra le numerose Elohim, con similitudini con le divinità mesopotamiche e grecoromane, la cui evoluzione fino allo status di testo sacro è un processo lungo e complesso.
