Il declino del latino nella scuola media: un’analisi storico-pedagogica
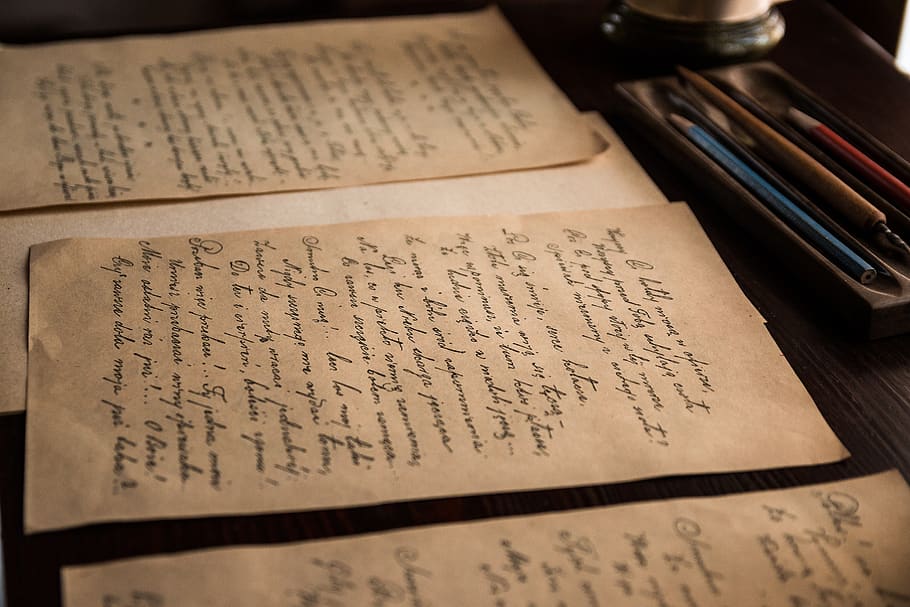
Nel 1978, l’insegnamento del latino nella scuola secondaria di primo grado venne abolito, decisione presa in seguito a pressioni derivanti da un’ideologia scolastica “populista” del 1878. Oggi, però, numerose istituzioni scolastiche stanno riconsiderando l’introduzione di questa disciplina, riconoscendone il valore formativo e la sua importanza nello sviluppo della consapevolezza sociale negli studenti. Spesso, il latino viene proposto in terza media, o addirittura come progetto di poche ore; una soluzione inadeguata, poiché almeno due anni di studio sono necessari per ottenere risultati concreti. La scuola secondaria di primo grado, proprio per la sua natura obbligatoria e formativa, ha il dovere di fornire agli studenti le basi per una solida cultura, ampliando il loro bagaglio di conoscenze e preparandoli a diventare cittadini consapevoli.
Ma come si è giunta a questa situazione e perché oggi si dovrebbe rivalutare la presenza del latino nel curricolo scolastico? L’analisi di Manuele Ambrosini evidenzia come, a partire dal 1958, nell’ottica di una presunta democratizzazione, si delineò il progetto di una scuola media uniforme per tutti, con obbligo scolastico a quattordici anni. Il latino divenne simbolo di divisione tra una scuola elitaria e una scuola di massa, dando luogo a accesi dibattiti pubblici, con i giornali che si schieravano a favore o contro. Queste discussioni, pur coinvolgendo la popolazione, dovettero fare i conti con l’alto tasso di analfabetismo italiano, che limitava la diffusione del dibattito.
Carlo Casalegno, in un articolo su “La Stampa” del 20 settembre 1962, evidenziava la necessità di superare le motivazioni politiche per trovare la soluzione didatticamente migliore, rifiutando l’idea di un approccio facoltativo al latino, considerato un prerequisito fondamentale per la comprensione della materia. La Democrazia Cristiana (DC), inizialmente restia a cedere alle pressioni delle forze laiche di sinistra, in seguito si aprì al dialogo. Panfilo Gentile, liberale, nel 1962 descrisse lo scontro politico tra sostenitori e oppositori del latino, con i socialisti che sostenevano che la soppressione del latino non eliminava, ma solo posticipava, le disuguaglianze sociali. La difesa della cultura umanistica, da parte di ambienti liberali e cattolici, si intrecciò con quella del latino come elemento identitario culturale. In Commissione Istruzione e Belle Arti, le posizioni divergenti ostacolarono l’approvazione di una legge unitaria, con proposte di legge presentate sia dai comunisti (Donini e Luporini) che dal ministro Medici. Il latino divenne il nodo centrale del dibattito, rappresentando per alcuni la difesa di una scuola elitaria e per altri il simbolo della discriminazione di classe.
Già in una lettera a Tristano Codignola emergeva la necessità di distinguere tra una cultura generale indispensabile per formare una “classe dirigente veramente democratica” e una cultura specialistica di livello universitario. L’Accademia dei Lincei, sottolineando l’importanza dell’uguaglianza sociale, affermò che l’abolizione o l’indebolimento dello studio del latino avrebbe impoverito la formazione intellettuale e il livello degli studi superiori. La relazione di Scaglia, presentata dalla VIII Commissione Istruzione e Belle Arti della Camera, evidenziò il valore formativo del latino per l’apprendimento dell’italiano, la sua funzione non discriminatoria e il suo contributo alla crescita morale ed educativa degli studenti, anche di quelli che non avrebbero proseguito gli studi classici. La DC si aprì all’inclusione di studenti con diverse capacità, mentre l’azione delle forze di sinistra, in particolare dei socialisti, contribuì a mediare tra le diverse posizioni.
