L’eruzione del Vesuvio del 1944: un ricordo indelebile
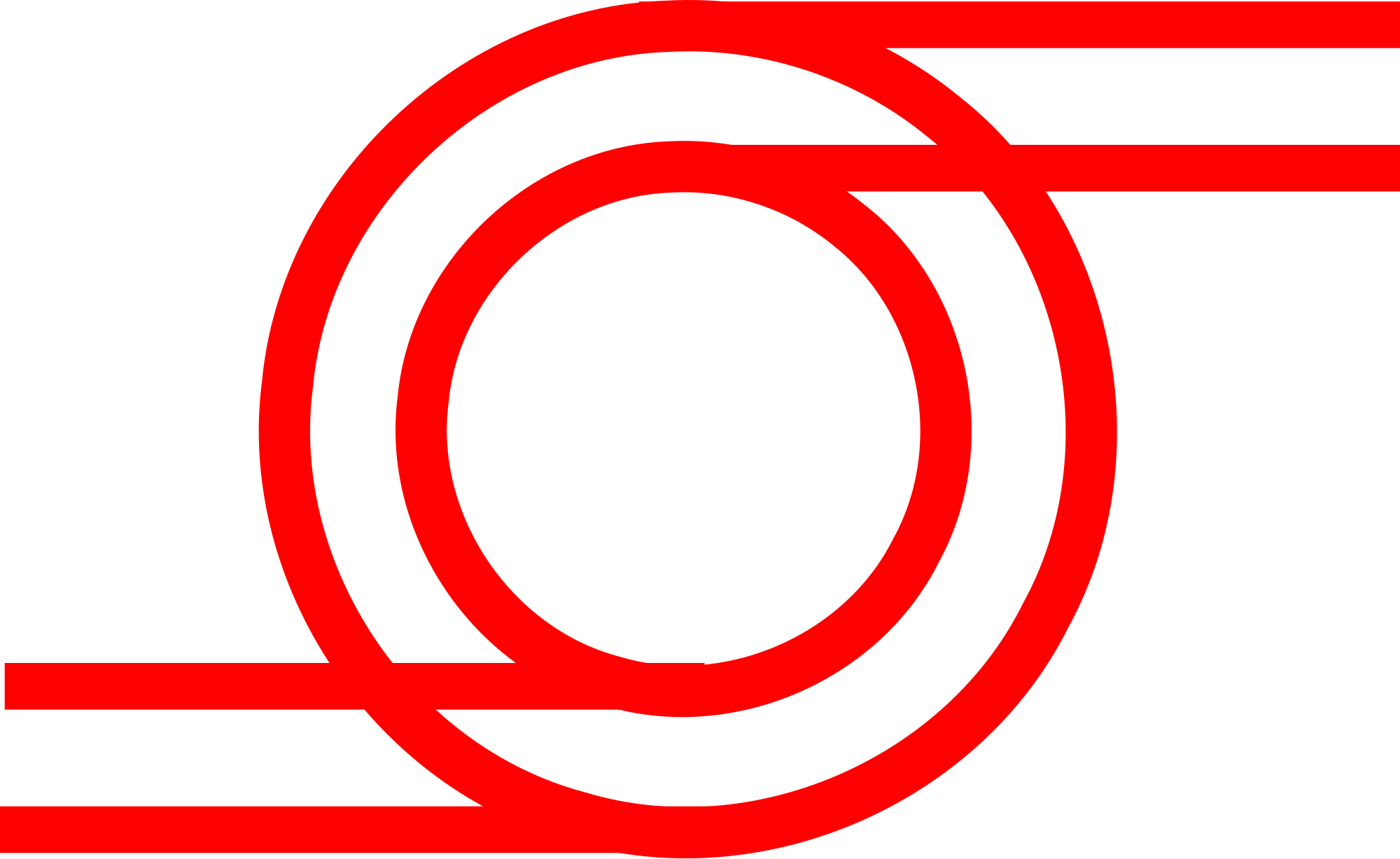
Il 18 marzo del 1944, esattamente settant’anni fa, il Vesuvio diede inizio alla sua ultima eruzione, un evento intensamente documentato dalle forze alleate stanziate nella zona. La catastrofe iniziò alle 16:30 del 18 marzo, a seguito del crollo quasi totale del conetto centrale avvenuto la notte precedente. Nel pomeriggio dello stesso giorno, la lava fuoriuscì da una fessura del cono, attraversando l’Atrio del Cavallo e dirigendosi verso Massa di Somma e San Sebastiano al Vesuvio. Inizialmente, la colata lavica si propagò a velocità elevata, tra i 50 e i 100 km/h, rallentando poi la sua corsa per raggiungere e devastare i due paesi la sera successiva. Contemporaneamente, sul versante occidentale, un’altra colata distrusse la funicolare e i binari della vecchia ferrovia a cremagliera. Il 21 marzo, alle 17:00, l’attività eruttiva si intensificò con spettacolari fontane di lava che raggiunsero diversi chilometri di altezza. Dall’alba del 22 marzo, una miscela di vapore, sabbia, cenere, scorie e, soprattutto, lapilli, spinti dal vento, ricoprì le aree circostanti, in particolare Angri, Pagani e Nocera. A Poggiomarino caddero scorie fino a 1 kg, mentre a San Giuseppe Vesuviano si registrarono frammenti di 15 cm di diametro. A partire dal mezzogiorno del 22 marzo, l’eruzione divenne esplosiva, con l’emissione di detriti rocciosi provenienti dal collasso del condotto vulcanico. Una nube eruttiva gigantesca, alta circa cinque chilometri, si formò nel cielo. Un gruppo di bombardieri americani, di ritorno da un bombardamento su Montecassino e in fase di atterraggio nei pressi di Terzigno, subì gravi danni a causa della pioggia di lapilli, alcuni dei quali di dimensioni considerevoli (fino a 15 cm), che provocarono profonde lacerazioni nelle strutture degli aeromobili, compromettendone l’aerodinamicità. Sui paesi vesuviani e sull’Agro Nocerino, lo strato di lapilli raggiunse in media gli 80 cm di altezza, causando il crollo di numerosi tetti e decine di vittime. La popolazione, proteggendosi come poteva, si adoperò a rimuovere i lapilli dai tetti e dalle terrazze, contribuendo paradossalmente ad aumentare l’accumulo nelle strade, che in alcuni punti raggiunse i tre metri. Si rese quindi necessario trovare siti per lo smaltimento dei detriti; nei giorni successivi, furono riempiti pozzi, ingressi di antiche cave di tufo, campi coltivati e vasche di raccolta delle acque e dei detriti provenienti dai monti (opere di bonifica del 1806). Alle 14:00 del 23 marzo iniziò una fase sismo-esplosiva, con forti tremori causati dai gas che spostavano le rocce crollate e ostruivano il condotto vulcanico. Il 24 marzo, una densa nube di cenere bianca ricoprì il cono, creando un effetto simile a una nevicata. Il 26 marzo ebbe inizio la fase conclusiva, con un progressivo diminuire delle esplosioni; il 29 marzo l’eruzione si estinse. Tuttavia, fino alla fine dell’anno, emissioni di anidride carbonica (mofete) da vari pozzi e dal terreno causarono almeno altre due vittime. L’eruzione espulse circa 70 milioni di metri cubi di lava, causando decine di morti per il crollo di tetti e solai.
